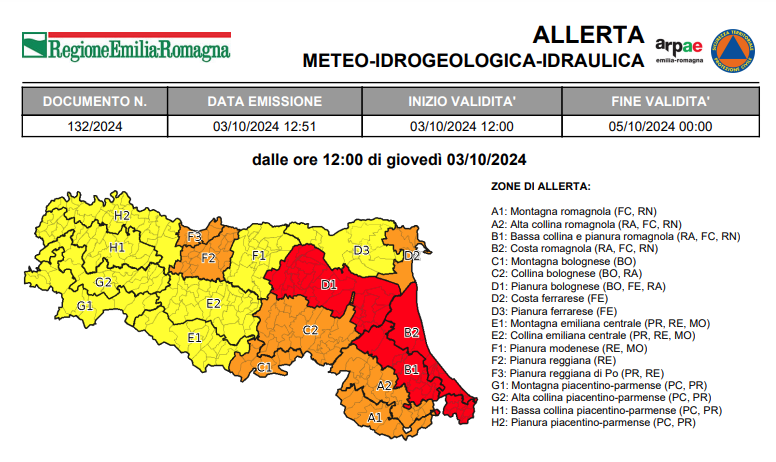Dall'Italia
Coronavirus, un operatore socio-sanitario nel bergamasco: “Qui il contagio è quotidiano. Bisogna rispettare le regole”

“Bisogna assolutamente avere il massimo rispetto delle indicazioni delle istituzioni. Dobbiamo chiederci: preferiamo che ci si ammali tutti oggi, oppure tornare ad essere consumatori domani? Perché il rischio è che la cosa sia molto più grande di ciò che pensiamo”: l’appello viene da chi sta sperimentando in prima persona l’altissima tensione che si vive nelle strutture sanitarie nella zona a più alta incidenza di coronavirus in Italia, nel bergamasco. All’indomani della decisione del governo italiano di rendere tutto il Paese zona protetta, con l’invito a restare a casa per arginare il contagio, Federico Trebbi, 43 anni, bolognese, operatore socio-sanitario nella Fondazione I.P.S Cardinal Giorgio Gusmini onlus, con sede a Vertova, paesino di 5000 abitanti, in Val Seriana a 10 km da Alzano e Nembro (tra i paesi con il più alto numero di contagi), racconta la durissima situazione nella struttura in cui lavora. Uno dei consiglieri, Ivo Cilesi, 61 anni, è stato tra le prime vittime del coronavirus: era tra i massimi esperti di Alzheimer e aveva inventato la terapia della bambola.
Nella struttura 64 operatori a casa in malattia. La struttura accoglie 250 pazienti: dalle Residenze sanitarie assistite per anziani al reparto hospice che accompagna i malati terminali. Altrettanti sono gli operatori. Trebbi lavora nel reparto per malattie neurovegetative – persone con ictus o gravi patologie celebrali – altamente specializzato nella Sla e accreditato con il Servizio sanitario nazionale. Gli operatori socio-sanitari si occupano della fase assistenziale che comporta il maggior contatto con il paziente: igiene personale, mobilitazioni, sollevamento dai letti per metterli in carrozzina. Quindi tutte operazioni che comportano una distanza inferiore a quella di sicurezza di un metro e che vanno svolte in due. Al momento sono a casa in malattia 64 operatori.
Per motivi di privacy non è dato sapere se di Coronavirus o altro.
“Ma per chi come noi lavora in un contesto così delicato e a rischio – osserva, precisando di parlare a titolo personale – sarebbe indispensabile saperlo”. Solo il caso di un medico è conclamato.
“Ogni giorno due nostri colleghi devono restare a casa. In questa zona il contagio è quotidiano”.
“Il problema in questo momento non è più il virus, è la gente”, sostiene Trebbi. Lo stress prolungato, “l’ansia necessaria” e la fatica di settimane senza riposi per sostituire i colleghi, ma soprattutto il timore di far ammalare i propri cari – perché persone esposta al rischio – trapelano dalle sue parole. Una comprensibile emotività che chiunque faticherebbe a tenere a bada. Proprio ieri, primo giorno di tregua, ha deciso di trasferirsi in un appartamento da solo, per non rischiare di trasmettere un eventuale contagio ai familiari, tra cui due ragazzi di 7 e 17 anni. In reparto indossano ogni giorno le mascherine chirurgiche e solo da qualche tempo sono state vietate le visite dei parenti. “La nostra struttura ha fatto tutto quello che poteva per seguire alla lettera le indicazioni dell’Istituto superiore della sanità – dice – ma fuori tutti hanno continuato a svolgere la stessa vita di prima, con contatti umani e sociali. Molti non hanno rispettato le regole che avrebbero potuto evitare l’espansione del contagio”.
“Fino a ieri i bar erano pieni fino alle 18, la gente in giro”.
Tanti amici e conoscenti con il Coronavirus. Trebbi snocciola storie di amici e conoscenti toccati direttamente dal Coronavirus e di sanitari che lavorano in rianimazione nell’ospedale di Bergamo: “Non sono tutti anziani, ci sono anche tanti giovani intubati”. Se il virus si manifesta con una febbre molto lieve il tampone viene effettuato a discrezione della sanità italiana. Il suo timore è che in questo modo “continuiamo ad espandere la malattia”. “Siamo certi – afferma – che
intorno a noi ci sono molti più ammalati di Coronavirus di quanti siano ufficialmente dichiarati”.
Un lavoro difficile, quelli degli operatori socio-sanitari, “che non si può interrompere perché altrimenti la gente muore”. Si tratta di pazienti neurovegetativi e Sla, fisicamente immobili e attaccati al respiratore. Va fatta la broncoaspirazione, vanno cambiati perché altrimenti rischiano piaghe da decubito. “E’ un mestiere complicato che non si fa per soldi – spiega – perché guadagni 1100 euro al mese lavorando 38 ore a settimana. Ma hai nelle mani la vita di queste persone. Lo fai per dare sollievo agli altri. Ma oggi con il Coronavirus è diventato tutto molto più complicato. Moralmente non me la sento di licenziarmi e riparlarne tra due mesi. Se facessimo tutti così morirebbero più pazienti per altre patologie”.
Le cautele nelle strutture sanitarie. L’unica cosa che si può fare nelle strutture sanitarie, a suo avviso, “è mettersi il più possibile nelle condizioni di lavorare in sicurezza: mascherine chirurgiche, lavarsi le mani, utilizzare la soluzione alcolica ed avere il minor numero di contatti con i pazienti e con gli operatori socio-sanitari, che svolgono sempre il servizio in coppia”. Trebbi chiede, in particolare, “informazioni più chiare possibili”:
“In caso di contagio conclamato ci dovrebbe essere un isolamento totale, anche tramite l’abbigliamento dell’operatore entrato in contatto con il contagiato e mascherine con filtri”.
“Siamo tutti nella stessa barca”. Moralmente e psicologicamente è pesante. La solitudine e l’allontanamento dalle persone care è dolorosa: “Ora cerco solo di fare il mio dovere e lavorare senza pensare troppo”, dice. La sua speranza “è che gli italiani per una volta non facciano gli italiani e rispettino le regole. Perché se non siamo uniti diventiamo una barca destinata ad affondare”.
“Non esiste la possibilità di ingannare questa malattia se non si va tutti in una unica direzione”.